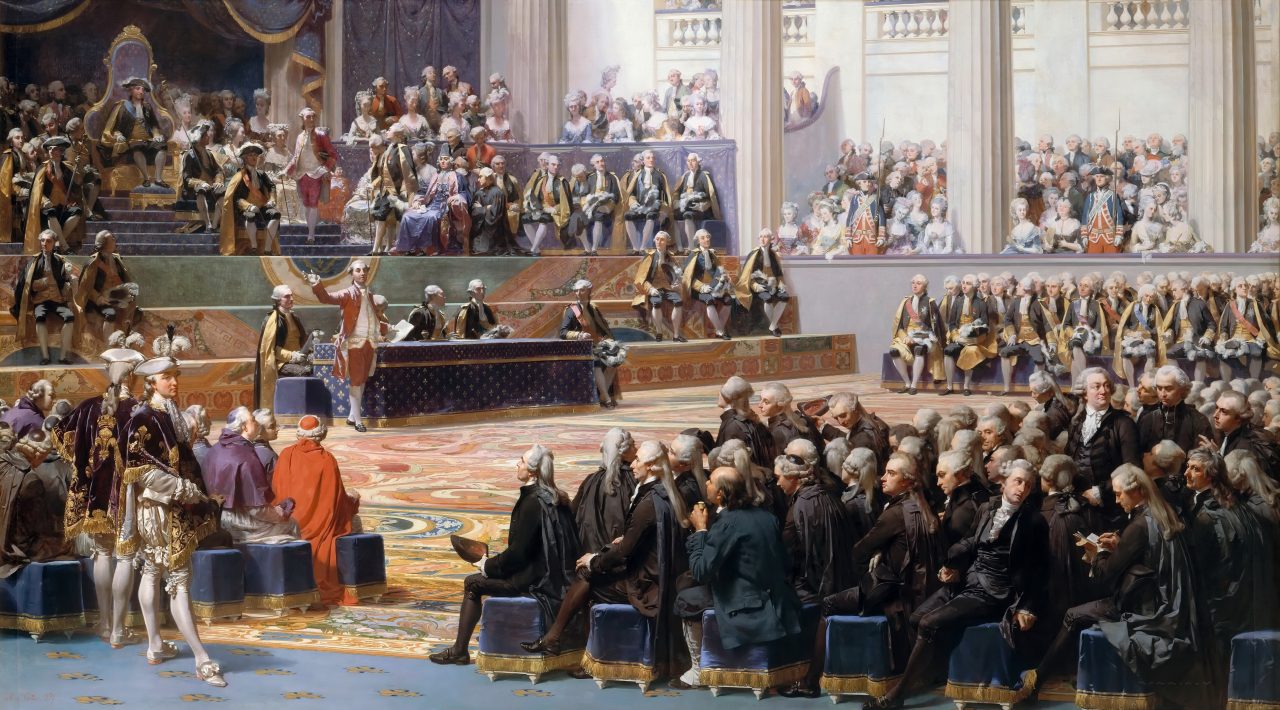È innegabile che in Italia sia importante premiare di più il merito, ma la meritocrazia, figlia di un connubio ideologico tra moralismo e neopositivismo, potrebbe rappresentare un grave problema proprio per chi la invoca. È una medicina che vorrebbe rendere la società più efficiente e la vita dei singoli più giusta, ma rischia di aumentare lo stress da competizione generando ancora più ingiustizie.
È una parola che sembra antica, inganna perché suona come democrazia, in realtà è stata inventata dal sociologo laburista inglese M. Young nel 1958. Letteralmente significa “potere al merito”.
Esiste addirittura una formula per definire il merito: m=IQ+E, quindi il merito è il risultato della somma del Quoziente di Intelligenza QI più lo sforzo E. Da una parte una dote naturale e dall’altra l’impegno personale.
Prendiamo per buona la formula e ragioniamo sui suoi addendi: il QI dipende certo dall’educazione ricevuta e da fattori che sono sociali ed ambientali (non c’è grande merito in tutto ciò, hai solo vinto la lotteria della vita) e l’impegno dipende dal giudizio degli altri, dal contesto storico e politico, non può certamente essere un fatto oggettivamente misurabile, né può contare l’autovalutazione. Il merito infatti viene valutato da qualcuno che stabilisce i criteri e valuta. Nella società staliniana o in qualsiasi dittatura il criterio del premiare lo sforzo, che pure era ben presente, non ha certo creato una società giusta.
Insomma anche se c’è una formula a me sembra un pasticcio che ci aiuta poco a definire il merito e come valutarlo.
Quando Young scrisse il suo saggio nel quale inventava la parola meritocrazia, non gli attribuiva certo un valore positivo: la sua era una critica profonda ad ogni sistema che si fosse basato su questo concetto. Per lui questo principio era letteralmente pericoloso poiché, Aristotele l’aveva già detto, il principio meritocratico sarebbe stato l’anticamera della tecnocrazia oligarchica, l’annullamento della democrazia.
Ha certamente senso che chi merita di più ottenga di più, non fino al punto di attribuirgli un vantaggio eccessivo rispetto agli altri; né è accettabile l’egualitarismo, l’1=1, anche se tutte le persone devono avere garantito uguale trattamento ed uguali opportunità, che è il contrario della meritocrazia.
Come si vede il problema del merito non è così semplice da districare.
Se definiamo la tanto invocata meritocrazia come l’idea guida di una società in base alla quale le responsabilità vanno attribuite a coloro che mostrano maggiore intelligenza e doti naturali, oltre ad avere un maggiore impegno nello studio, nel lavoro e nella vita, il problema in realtà non si chiarisce ed il risultato può risultare paradossale: tutti gli ambiti nei quali la meritocrazia è regola, in particolare quando è possibile applicare criteri “oggettivi”, producono diseguaglianze economiche e sociali. Pensiamo ad esempio allo sport professionistico nel quale il merito è valutato sulla base dei risultati misurabili conseguiti: una analisi dei compensi dei professionisti mostra come negli ultimi 30 anni il primo 10% abbia visto crescere le proprie retribuzioni circa 10 volte di più della crescita media in quello sport. È logico, se ci pensiamo, chi ha più soldi è disposto a pagare per accaparrarsi il primo e se non può il secondo e così via, ma quando sei l’ennesimo?
Che cosa succede invece quando i criteri di valutazione del merito sono meno quantificabili, cosa succede in pratica nella scuola, nel mondo del lavoro o delle professioni? La strada che normalmente si segue è quella del valutare i risultati: hai conseguito una laurea? Hai vinto un concorso? Hai lavorato in una certa azienda? Più sono alti i risultati conseguiti, più la società meritocratica ti premia. E gli altri? La società meritocratica li punisce: se il tuo voto di laurea non è alto, se non ti sei laureato in una università di un certo tipo, se non sei arrivato tra i primi ad un concorso e così via è solo colpa tua! Non ce la fai a competere e quindi non te la puoi prendere con nessuno: la colpa del tuo fallimento è solo tua.
In pratica il merito viene misurato sulla base del curriculum. Partiamo dalla scuola: Thomas Piketty, noto studioso francese che si occupa delle disuguaglianze nella società, ha messo in evidenza che vi è una stretta relazione tra la geografia economica delle grandi città ed il prestigio delle scuole. I più ricchi si concentrano in alcune zone, che sono quelle dove hanno sede le scuole con una più alta reputazione. Da sempre le élite che si sono formate nelle scuole di eccellenza tendono a rigenerarsi: i figli seguono spesso il percorso dei genitori, e per fortuna a volte anche i ricchi hanno figli stupidi o svogliati, altrimenti i ricchi sarebbero sempre più ricchi ed i poveri sempre più poveri.
Se poi si passa alla ricerca del lavoro, specie all’inizio, la valutazione dei candidati è certamente influenzata dalle scuole frequentate. D’altra parte scrivere un progetto in un buon inglese, parlare correntemente più lingue o superare un colloquio con una valutazione alta spesso dipende più dal contesto sociale di provenienza che dalla maniera con cui si è seguito il curriculum di studi.
In un processo di selezione è il merito che favorisce alcuni a discapito di altri o sono stati principalmente altri fattori?
Insomma in una società perfettamente meritocratica le disuguaglianze economiche e sociali tendono ad aumentare, mentre la competizione, le lotte, la frustrazione della maggioranza delle persone crescono e la meritocrazia concede una patente di moralità e legittima questo modello sociale.
Dove è finita la richiesta di democrazia che cercava di offrire a tutti una partecipazione alla società in piena uguaglianza? Dov’è la libertà di scelta educativa: è rimasta solo come dichiarazione di intenti nella nostra Costituzione?
Io credo che si debba perseguire l’idea di premiare il merito, ma quest’idea per funzionare necessità di una forte dose di recupero della responsabilità di chi sceglie. Deve essere spogliata della componente moralistica neopositiva. Gli esami a crocette apparentemente promuovono il merito, in realtà fingono di rendere oggettiva la valutazione, dimentichiamo la pretesa di oggettività nel valutare le persone: non è possibile, è una pericolosa illusione.